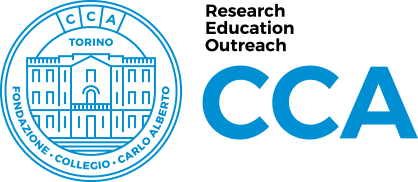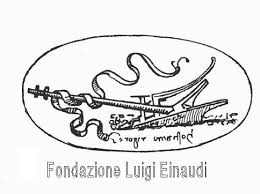di Alessia Amighini e Andrea Goldstein
Sebbene i dati sull’andamento dell’economia cinese del primo semestre 2015 lasciano ormai ben pochi dubbi sull’effettiva capacità del governo di traghettare il paese in modo indolore verso un nuovo modello di crescita (il cd New Normal al 7% annuo, annunciato alla fine del 2014), all’origine del crollo delle borse cinesi della scorsa estate vi è l’incoerenza delle misure adottate per farvi fronte, e l’incertezza sul corso futuro della politica economica di Pechino. La crisi di borsa di agosto è stata causata, oltre dal rientro fisiologico dai corsi gonfiati dell’ultimo anno (+150% a Shanghai), in gran parte dall’incertezza sulle priorità e dall’incoerenza di Pechino sulla determinazione a mantenere la stabilità economica e finanziaria nel corso della transizione.
Dall’inizio di luglio, infatti, le autorità cinesi hanno mostrato reazioni, da un lato incoerenti di fronte ai ripetuti crolli dei mercati, e dall’altro lato, incompatibili con la volontà dichiarata di adottare riforme di mercato. Col duplice obiettivo di liberalizzare progressivamente il mercato finanziario (il più chiuso e regolamentato del paese) e di creare canali di investimento alternativi all’immobiliare, il governo a metà del 2014 aveva introdotto la possibilità di acquisti a leva, incentivando in tal modo gli investimenti in borsa di molti piccoli e grandi risparmiatori e imprese. Dopo una simile apertura al meccanismo di mercato, senza precedenti in Cina, ai primi di luglio ha vietato la vendita dei pacchetti azionari superiori al 5% per sei mesi, congelando miliardi di Rmb di ricchezza dei più grandi investitori cinesi: un ritorno in grande stile del vecchio dirigismo di stampo pechinese. Ancora, dopo il blocco delle contrattazioni e gli acquisti massicci di titoli (per circa $200 mld) nelle due settimane precedenti per sostenere i corsi, il 14 Agosto il regolatore cinese aveva dichiarato che non sarebbe intervenuto più in tal modo, per poi stanziare di nuovo, il 27 agosto, $220 mld per l’azione della China Finance Security Corporation.
E’ vero che la fuga degli investitori dalle borse cinesi era in buona parte attesa: come sempre accade negli epiloghi delle bolle speculative – di cui l’aumento del 150% dei prezzi azionari a Shanghai nell’ultimo anno era un chiaro esempio – le prime avvisaglie di inversione di tendenza innescano una serie di correzioni a catena. Ma in questo caso c’è molto di più. Non si tratta solo di un forte calo di fiducia nella capacità di Pechino di gestire un atterraggio morbido dell’economia cinese verso un sentiero di crescita più contenuta rispetto al passato, ma più sostenibile. Quello da cui gli investitori (peraltro quasi esclusivamente cinesi) stanno fuggendo è un paese che introduce progressivamente il meccanismo di mercato (una decisione economica), ma che non è certamente pronto e forse neppure intenzionato ad accettare l’esito di tale meccanismo in termini di allocazione delle risorse (una decisione politica). E dà segnali, da un lato incoerenti sul corso futuro delle azioni del governo sulla strada delle riforme, e dall’altro lato invece coerenti con il solito atteggiamento dirigista di Pechino.
Gli eventi di quest’estate mostrano che Pechino tentenna e temporeggia, creando un clima di incertezza che è peggiore della certezza del cd New Normal. Dopo aver incentivato gli investimenti in borsa di molti piccoli e grandi risparmiatori e imprese (come alternativa all’immobiliare già surriscaldato) permettendo le operazioni a leva, ai primi di luglio il regolatore ha congelato miliardi di yuan, vietando per sei mesi la vendita di pacchetti azionari superiori al 5%. Poi ha bloccato le contrattazioni e ha massicciamente acquistato titoli per due settimane, salvo fare marcia indietro il 14 Agosto.
Anche la svalutazione del Rmb iniziata lo scorso 11 Agosto è avvenuta in un contesto di forte instabilità dei mercati, e ciononostante è stata (più o meno volutamente) presentata in modo ambiguo. La revisione del meccanismo di adeguamento della parità centrale della banda di oscillazione all’interno della quale fluttua il Rmb (rispetto a un paniere di valute tra cui dollaro, euro e yen) ha prodotto un riequilibrio del valore del Rmb in linea con l’andamento del mercato, vicino al limite inferiore della banda di oscillazione (-2% rispetto alla parità centrale) dall’inizio del 2015. Da tempo suggerita anche dal Fondo Monetario Internazionale, non è una (semplice) svalutazione competitiva: nell’ultimo decennio l’export cinese è aumentato rapidamente nonostante l’apprezzamento del tasso di cambio, sia nominale rispetto al dollaro, sia reale effettivo (entrambi di circa il 30%) e oggi non serve competere ulteriormente sul prezzo ma se mai sulla qualità, che non si guadagna di certo manovrando il tasso di cambio. I mercati, invece, hanno interpretato la manovra come semplice, impulsiva e forse improvvida reazione al rallentamento dell’economia, e questo ha accelerato le vendite in borsa. I principali partner commerciali della Cina, e non a caso soprattutto quelli che nei suoi confronti registrano un grande disavanzo, cioè gli Stati Uniti, hanno subito gridato al ladro, sempre pronti a incolpare il tasso di cambio cinese di tutti gli squilibri macroeconomici nazionali e globali.
E così la grande volatilità e le brusche virate dei mesi estivi sono il segnale di un calo della fiducia dei mercati nella dirigenza cinese piuttosto che nella sua economia, che cresce pur sempre del 6% all’anno (poco per la media cinese ma molto più di ogni altra economia avanzata ed emergente) e resta comunque il mercato più dinamico del mondo, uno dei principali per molti settori e per gran parte delle multinazionali. A tutt’oggi la Cina è stato un paese molto stabile rispetto ad altri, soprattutto ad altri paesi emergenti, perché il governo tende a tenere le redini molto strette per evitare bruschi scossoni, ma gli eventi di quest’estate l’hanno reso pericolosamente simile ad alcuni grandi paesi emergenti. Gli investitori hanno capito che forse Pechino vuole sperimentare, più che introdurre completamente, i meccanismi di mercato, a scapito dei rendimenti degli investitori che quindi hanno cominciato a vendere.
Forse in parte incaute e inesperte, di certo impreparate, le autorità di Pechino in questi mesi sono di fronte a una contraddizione di fondo tra gli obiettivi economici di breve (mantenere uno stretto controllo del governo sulla crisi di borsa per garantire la stabilità finanziaria) e di medio periodo (introdurre progressivamente le riforme di mercato). Le autorità cinesi oggi si trovano a dover affrontare troppi problemi nello stesso tempo: dovrebbero aumentare la liquidità, ma questo spingerebbe ulteriormente la svalutazione che invece non vogliono per molti motivi: aumenterebbe ulteriormente la fuga dalle borse e renderebbe ancor più costose le importazioni degli input su cui si reggono molte delle filiere produttive nelle quali le imprese cinesi e a capitale misto svolgono le fasi a valle della catena del valore.
La transizione verso un nuovo modello economico non è fallita, ma di certo la grande componente di domanda interna, cioè la domanda di abitazioni, è venuta meno perché in buona parte gonfiata e in parte drogata dalla costruzione di case che sono rimaste vuote. La vera fonte della crescita cinese dei prossimi anni dovrà essere il consumo delle famiglie, non gli acquisti di abitazioni, ma questo è ancora difficile da ottenere perché le famiglie cinesi risparmiano molto soprattutto per motivi precauzionali, per l’istruzione e la sanità. Il nuovo modello richiede anche una serie di condizioni che riguardano la governance. Negli ultimi due anni il governo cinese è andato verso un accentramento delle decisioni politiche ed economiche, per far fronte al rallentamento dell’economia che ha richiesto più potere al centro e meno a livello delle province che sono state molto indisciplinate nelle voci di spesa per farsi belle con Pechino. Il contratto sociale alla cinese è entrato in crisi, perché la diseguaglianza è aumentata e questo fa capire a chi non è riuscito ad aumentare il proprio benessere che forse un sistema politico autoritario e centralizzato non è compatibile con una società prospera in un’economia di mercato, se non al prezzo della disuguaglianza e dell’armonia cinese.
Da quasi 40 anni Pechino gestisce la transizione economica in maniera eclettica, preferendo gli esperimenti all’alternativa del Big Bang senza rete di protezione. Difficile, ma non impossibile, quando gli obiettivi di politica economica – inclusa quella commerciale, industriale e valutaria – convergevano in modo coerente sulla crescita della produzione e delle esportazioni. In questi mesi sta invece cercando d’introdurre simultaneamente svariati cambi negli ingranaggi dall’esito incerto lasciando il motore in piena corsa. Apparentemente quasi impossibile, soprattutto quando gli obiettivi sono molteplici, economici – riequilibrare le fonti della crescita (meno investimenti, soprattutto nell’immobiliare e nel manifatturiero, più consumi, se possibile di servizi) senza sgonfiarla troppo – ma anche politici– interni, mostrare ai cittadini cinesi che il PCC è in grado di far correre l’economia sulle proprie gambe, ed esterni, convincere il resto del mondo che la Cina è pronta a garantire la Pax economica sinica. Anche se le vie della Cina sembrano infinite, questa volta per le abili autorità di Pechino gli obiettivi macro sembrano troppi e divergenti, e gli strumenti pochi.
Nel breve periodo, per evitare eccessiva instabilità finanziaria, Pechino può aumentare liquidità, oppure intervenire direttamente acquistando sul mercato aperto e riducendo le riserve obbligatorie delle banche. La seconda opzione mette a rischio la possibilità di essere ritenuta meritevole dello status di economia di mercato; allontana il sogno cinese di fare del renminbi la seconda valuta forte del sistema finanziario internazionale; e in più le banche (tutte di proprietà pubblica) favoriscono le imprese a capitale o controllo pubblico, e di conseguenza penalizzano gli investimenti privati più profittevoli e incentivano la crescita di settori già in eccesso di capacità. Il quantitative easing però favorisce ulteriormente la svalutazione del tasso di cambio, che suscita le ire dei suoi principali partner commerciali, soprattutto degli Stati Uniti, rende più care le importazioni di componenti che poi vengono assemblati in Cina (pensiamo ai processori e agli schermi per i PC e gli smartphones) e a sua volta incentiva la fuga di capitali.
Ormai i nodi di politica economica sono venuti al pettine, alla lunga per i governanti cinesi sarà arduo esimersi dal compito inedito di scegliere tra le priorità. Se il motore dell’economia cinese deve essere alimentato dal consumo privato (oggi in diminuzione), dalle tecnologie e dall’imprenditorialità, Pechino dovrà mostrare con i fatti di voler fare più spazio al mercato. Resta da vedere se sarà facile, politicamente, convincere i cinesi ad accettarne tutte le conseguenze.
La visita di questa settimana di Xi negli Stati Uniti ha anche l’obiettivo di rassicurare gli investitori americani sulla tenuta dell’economia cinese e sulla bontà del proprio processo di trasformazione. Le riforme avviate nel 2013 e il riconoscimento di una condizione di “nuova normalità” dell’economia cinese indirizzano la Cina verso una maggiore dipendenza dai consumi interni a scapito di investimenti e esportazioni. Tuttavia, il passaggio da un modello economico all’altro prevede tempi più lunghi di quanto preventivato dalle autorità cinesi durante i quali potranno facilmente verificarsi episodi di grande instabilità economica e finanziaria come quello cui abbiamo assistito la scorsa estate.
Al vertice di Washington, Xi porta alcuni dei temi portanti della riforma dell’economia cinese: le infrastrutture digitali, la green economy e il ruolo del mercato. Xi si è fatto accompagnare dai rappresentanti delle più importanti e innovative aziende digitali cinesi (Alibaba, Tencent, Baidu e Lenovo), per ricordare all’America che la Cina è sempre il mercato più dinamico anche con il rallentamento in corso. Non sono però risolti i nodi sulle restrizioni a internet in Cina, che spaventano gli investitori stranieri. Anche l’annuncio di un possibile accordo sullo sviluppo della green economy punta alla sviluppo di settori innovativi in Cina.
E’ lungo queste linee programmatiche che verrà presentata in ottobre una prima bozza del 13mo piano quinquennale, un documento che determinerà l’indirizzo economico cinese fino al 2020. Se da un lato la riconversione energetica e la promozione di settori ad alta innovazione è ormai consolidata nelle linee programmatiche cinesi, si aspetta di capire come si svilupperà il rapporto fra pubblico e privato. La riforma delle imprese di stato, un passo cruciale per la trasformazione economica della Cina perché mette in discussione rendite economiche e politiche, per ora lascia molto a desiderare in quanto alla reale volontà di Pechino di introdurre meccanismi di gestione più trasparenti e logiche di mercato. E genera ulteriori perplessità sull’opportunità di accordare alla Cina lo status di economia di mercato, altro tema fortemente controverso e delicato. Infatti, nell’accordo in occasione dell’ingresso nel WTO nel 2001, la clausola che permetteva ai suoi partner commerciali di trattare la Cina come non-market economy scade nel 2016, e la Cina pretende di meritare quello status di diritto il prossimo anno, a prescindere dalle riforme realizzate in tal senso. Anche se tale clausola ha rilevanza soltanto in merito alle azioni anti-dumping (che sono molto più agevoli nel caso vengano sollevate nei confronti di un’economia non di mercato), per la Cina questo riconoscimento è un tema di prestigio internazionale, e per Xi di forza politica interna. Che la Cina non sia un’economia di mercato è indubbio. Così come è indubbio che il Rmb non rispetta le condizioni oggettive per essere inserito nel paniere delle valute di riserva del FMI. A Washington Xi porta tutto il peso e i legami economici della Cina nell’economia mondiale per reclamare maggior peso politico e ottenere sconti sui mancati progressi nelle riforme interne, sulla mancata trasparenza nella gestione del mercato finanziario, sulla reticenza nell’apertura del mercato interno alle imprese estere in molti settori importanti (soprattutto i servizi), e sulla discutibile condotta cinese in tema di cyber security. Forse troppi gli sconti chiesti per le mancanze da confessare?
Ora che i nodi di politica economica interna sono venuti al pettine, alla lunga per i governanti cinesi sarà arduo esimersi dal compito inedito di scegliere tra le priorità. Se il motore dell’economia cinese deve essere alimentato dal consumo privato (oggi in diminuzione), dalle tecnologie e dall’imprenditorialità, Pechino dovrà mostrare con i fatti di voler fare più spazio al mercato. Resta da vedere se sarà facile, politicamente, convincere i cinesi ad accettarne tutte le conseguenze.
*questa nota è liberamente tratta da alcuni articoli precedentemente pubblicati dagli autori:
‘Rischi politici nella bolla di Shanghai’ di Alessia Amighini e Andrea Goldstein, lavoce.info, 17 luglio 2015
‘La sfida del Premier Li: andare verso una “nuova normalità"’ di Alessia Amighini, Il Fatto Quotidiano, 25 agosto 2015
‘La Cina tra esperimenti di mercato e vecchio dirigismo’ di Alessia Amighini e Andrea Goldstein, lavoce.info, 26 agosto 2015
'Borse, dietro il panico ci sono le idee confuse di Pechino', di Alessia Amighini, Il Fatto Quotidiano, 30 agosto 2015
‘Incertezza e incoerenza all’origine della crisi cinese’ di Alessia Amighini, ISPI commentary, 31 agosto 2015